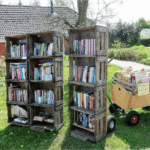C’è un condominio inatteso: lo vedi da lontano, sembra normale, ma quando ti avvicini cominciano i segnali. Piastrelle staccate, intonaco sfaldato, scale illuminate a sufficienza e balconi che un soffio basterebbe a far cedere. Sono i quartieri delle case popolari, impianti gestiti da enti pubblici regionali che promettono «casa dignitosa», ma spesso consegnano solo facciate di promesse e interni di abbandono.
È passato del tempo dal sisma, dalle New Town costruite in fretta; quei moduli antisismici dovevano essere temporanei, invece sono diventati permanenti. All’Aquila, nei progetti CASE di Preturo, Sassa e Arischia, centinaia di balconi sono stati sgomberati perché strutturalmente pericolanti: legno scadente non bullonato, materiali falsati, solai marci. Un balcone caduto è diventato il simbolo di una lunga emergenza non ancora risolta
Queste storie non riguardano solo una regione: scuotono il cuore del sistema pubblico di edilizia residenziale italiana. Circa 750.000 alloggi popolari ospitano due milioni di persone, gestiti da ATER, ALER, enti regionali che devono coniugare welfare e sostenibilità economica – una combinazione che, spesso, fallisce sul campo
Chi abita in queste case nel 2025? Sono cittadine e cittadini che vivono a canone sostenibile ma che si scontrano con scale buie, ascensori guasti, riscaldamenti malfunzionanti e, talvolta, con un senso di abbandono diffuso: i cittadini di serie B.
Cosa significa vivere in un alloggio con manutenzione rinviata
Immagina di bussare alla porta di una famiglia che abita lì da anni. L’appartamento è pagato in tempo, l’ISEE rientra nella soglia. Ma ogni volta che piove, l’acqua filtra dalla finestra. La caldaia viene accesa solo se strettamente necessaria. Il balcone, con crepe ormai visibili a occhio nudo, è un luogo che nessuno osa usare. Per la sicurezza, viene chiuso. Ma il suo abbandono riflette un’idea: nessuno ha mai considerato la vita quotidiana delle persone dentro quegli spazi.
E quel silenzio pesa. Come pesa il fatto che le segnalazioni vengono archiviate, rimandate, mai realizzate. In alcuni casi, così si convive per anni. Fino al giorno in cui la magistratura ordina lo sgombero: i balconi vanno abbattuti, i danni sono conclamati, le famiglie devono andare altrove, anche solo per un po’. Quella stessa casa popolare smette di essere un bene e diventa un atto di sopravvivenza.
Un sistema pubblico fragile e poco equo
Non si tratta solo di manutenzione. È la struttura del sistema a essere fragile. Le case sono di proprietà pubblica, ma i fondi necessari non arrivano mai a coprire le reali necessità della gestione. Le aziende casa, costrette dal pareggio di bilancio, dipendono dai canoni che spesso non coprono nemmeno il costo delle utenze. Il risultato? Tagli, ritardi, edifici lasciati a se stessi
E negli anni più recenti, fondi del PNRR e bonus per la riqualificazione esistono, ma nei fatti rimangono difficili da usare: la burocrazia non facilita la concretizzazione degli interventi. Solo alcune regioni hanno iniziato a digitalizzare la gestione, monitorare le assegnazioni, recuperare alloggi abbandonati
Ci chiediamo: chi abita in queste case è davvero cittadino di serie B?
Le domande che dovremmo porci sono pesanti:
- È giusto che chi paga anche un canone minimo debba convivere con edifici pericolanti?
- È tollerabile che le case popolari siano soggette a degrado mentre gli investimenti restano bloccati?
- Quale dignità sociale può avere chi abita là dentro, in quartieri dove l’asfalto è rotto, le luci spente e la manutenzione invisibile?
Se l’emergenza abitativa continua a essere gestita come problema residuale, quelle persone non sono invisibili solo nei numeri: rischiano di essere invisibili anche nei diritti.
Dove nasce la speranza: una cultura nuova dell’abitare pubblico
Il cambiamento non è impossibile. Serve volontà politica, programmi strutturali, riforme che mettano al centro il diritto all’abitare.
Serve un Piano Casa nazionale che finanzia la manutenzione ordinaria e straordinaria, riconosca l’edilizia sociale come servizio essenziale, incentivi partenariati pubblico‑privato trasparenti e renda i Municipi attuatori effettivi dei piani di riqualificazione urbana.
Serve che queste aziende diventino capaci di programmare, intervenire, informare. Serve che i residenti abbiano voce: mappe digitali degli alloggi, trasparenza sui sopralluoghi, assemblee periodiche e canoni indicizzati alla sostenibilità del servizio.
E serve anche che i condomini condividano informazioni: se una scala è pericolante, se il tetto perde, se i balconi sono cedenti, bisogna segnalarlo. Non come denuncia di chi vive la povertà, ma come segnale di comunità attiva che tiene alla propria casa.
Conclusione: abitare è un diritto, non un rischio accettato
In tutto lo stivale, migliaia di famiglie vivono nelle case popolari con lo stesso diritto di chi vive in centro città. Ma la realtà spesso dice altro: sofferenze invisibili in appartamenti che aspettano manutenzione da anni. Edifici che dovrebbero custodire la dignità, ma che invece pesano come macerie emotive.
Se questo modello non cambia, se la gestione resta subalterna ai vincoli contabili, se le regioni rimangono lente e inefficaci, allora sì, possiamo dire che chi abita in case popolari è trattato come cittadino di serie B.
E questo non è solo ingiusto: è inaccettabile.
Le case popolari possono e devono diventare senso di comunità, opportunità reali, luoghi di vita degna. E non basta parlarne una volta. Serve agire, monitorare, costruire. E reclamare che la dignità di una casa sia garantita, non per scelta, ma per dovere.
Perché abitare è un diritto. E vivere nella paura di un balcone che crolla è una violazione di quella dignità fondamentale.
Redazione